di VALERIA ROSSI – PREMESSA: “vista da me” non significa, ovviamente, che questa sia una storia inventata o “interpretata” solo dal mio punto di vista. Significa soltanto che è il modo in cui l’ho vissuta e in cui l’ho “sentita” io: perché, oltre alla cronistoria dei fatti, scriverò anche quelle che sono state le mie personali sensazioni in merito.
Se qualcun altro potrà/vorrà smentirmi, qualora trovi dati inesatti (sono andata completamente a memoria, quindi non escludo che qualche data, per esempio, possa essere imprecisa), o nel caso in cui abbia vissuto questo percorso in modo diverso, è liberissimo di replicare. La mia storia inizia dagli anni ’70, perché prima io non c’ero e quindi potrei parlare solo per sentito dire.
Chiedo scusa in anticipo per le foto dei libri: sono i libri che ho in casa io, che risalgono proprio agli anni citati e che quindi sono conciati malissimo un po’ perché sono vecchi, un po’ perché sono stati letteralmente consumati a forza di essere letti e riletti.Forse avrei potuto trovare immagini più “pulite”, ma mi è sembrato più simpatico metterci proprio i “miei-miei”.
 Anni ’70
Anni ’70
Io “addestrai” (si fa per dire) il mio primo cane nel 1971, senza avere la più pallida idea di cosa stessi facendo.
Semplicemente, per motivi che sarebbe troppo lungo spiegare qui, mi ero trovata tra le mani un pastore tedesco senza pedigree e volevo assolutamente fargliene avere uno (all’epoca era ancora aperto il LIR per tutte le razze, quindi si poteva iscrivere qualsiasi cane come capostipite). Per ottenere l’iscrizione al LIR occorrevano un Certificato di Tipicità (che si otteneva in esposizione) e un Certificato di Qualità Naturali che invece andava preso durante una prova di lavoro.
Fu quello il motivo per cui mi avvicinai al settore dell’addestramento cinofilo: “come” mi ci avvicinai, se volete, lo potete leggere nel mio e-book “Donne&Bestie” (spammarsi un po’ fa sempre bene alla salute…).
Qui dico solo che al mio primo impatto col mondo dell’agonismo cinofilo ebbi il più classico dei “colpi di fulmine”: e tre anni dopo aprivo il mio primo campo (sempre “si fa per dire”, visto che trattavasi di due box ritagliati in un microspazio concessomi da un allevatore di pointer, più prato antistante a cui potevo accedere solo nelle giornate e negli orari in cui non veniva utilizzato come quagliodromo, perché questo era).
I tre anni intercorsi tra la mia tragicomica prima esperienza e l’apertura del mio “campoide” li passai a girare come una pazza per mezza Italia cercando di “imparare il mestiere” (anzi, l’hobby, perché a quei tempi pensavo ancora che sarei diventata veterinaria e studiavo ancora per diventarlo) e quindi – grazie alla corposa sponsorizzazione di papà, perché altrimenti sarei arrivata al massimo a tre chilometri da casa – mi feci un’idea abbastanza precisa di “quel che passava il convento” all’epoca. E c’è da dire che passava davvero pochino, almeno in termini numerici.
 Ancora meno passava il campo librario-manualistico: quando mi fiondai speranzosa in libreria cercando “libri sull’addestramento”, il primo libraio mi rise in faccia e il secondo (cinofilo!) mi fece arrivare appositamente dalla Svizzera il libro di Piero Scanziani “Il cane utile”, introvabile in Italia.
Ancora meno passava il campo librario-manualistico: quando mi fiondai speranzosa in libreria cercando “libri sull’addestramento”, il primo libraio mi rise in faccia e il secondo (cinofilo!) mi fece arrivare appositamente dalla Svizzera il libro di Piero Scanziani “Il cane utile”, introvabile in Italia.
Per il “grande pubblico”, negli anni ’70, non esistono né scuole, né metodi, nè tecniche. Ci sono “quelli che addestrano i cani” (chiamati anche “quelli che ammaestrano i cani”) e ci sono i “dresseur”, che sono quelli che addestrano i cani, però da caccia.
Fine.
In realtà non è che gli addestratori siano proprio tutti uguali.
E’ vero che la scuola è una sola, quella tedesca: ma gli addetti ai lavori (quattro gatti) possono scegliere tra due possibilità. C’è infatti chi lavora prevalentemente sul rinforzo positivo (allora chiamato “premio”) e chi lavora prevalentemente – e in alcuni casi esclusivamente – sul rinforzo negativo.
Tra chi sceglie questa seconda via ci sono nuovamente due linee di pensiero: c’è chi pensa che il cane debba “sentirsi a disagio” finché non fa la cosa corretta, e c’è chi pensa che il cane debba “provare dolore” finché non fa la cosa corretta.
Questi ultimi, già allora, vengono definiti “macellai” (o direttamente “stronzi”) da chi ama e rispetta i cani, che quindi preferisce non avere alcun rapporto con loro.
Io faccio parte di questo novero: calci, strattonate e impiccagioni non solo non voglio usarli, ma non li voglio neppure vedere. Forse li denuncerei anche, se esistesse una legge contro il maltrattamento degli animali: purtroppo la legge non c’è, quindi mi limito a girare alla larga da questo genere di campi.
Io ho sempre e solo lavorato sul rinforzo positivo e sul predatorio (per gli attacchi): e continuo così, anche perché i risultati mi soddisfano. Non ho alcuna intenzione di arrivare ai campionati mondiali: a me interessa divertirmi con i miei cani e far divertire loro. Però qualche garetta qua e là la facciamo, qualche brevetto lo portiamo a casa e va bene così.
Anche chi lavora sul rinforzo positivo approva e mette in pratica la “punizione”: non come metodo di insegnamento, però, ma solo come correzione qualora il cane, pur avendo ormai capito benissimo quello che si voleva da lui, decida di fare diversamente.
A questo punto è fondamentale chiarire che non sono “io” la santa della situazione.
Il fatto è che l’importanza della “gentilezza” (non del gentilismo, che è un’altra cosa) è già ben nota a chiunque lavori con i cani rispettandoli ed amandoli.
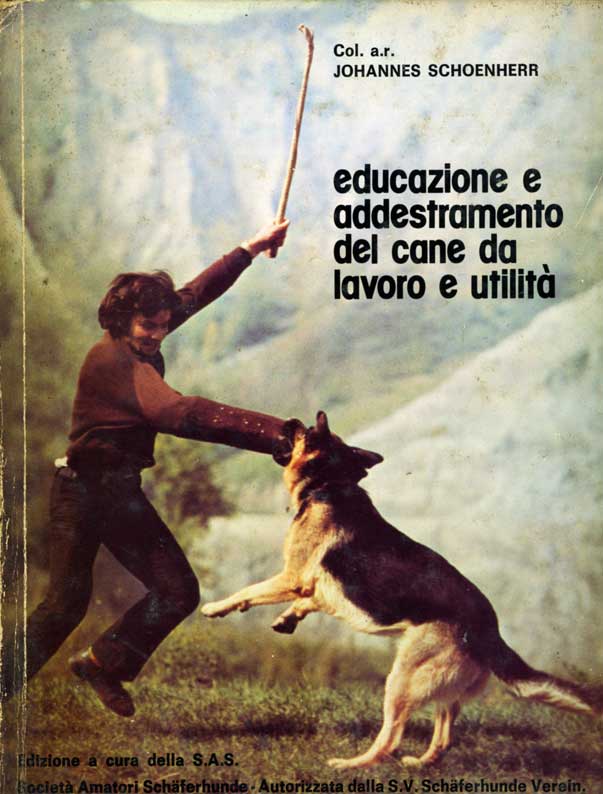 In un articolo di qualche tempo fa avevo già citato questo brano, che mi sembra giusto reinserire anche qui:
In un articolo di qualche tempo fa avevo già citato questo brano, che mi sembra giusto reinserire anche qui:
“Il profano crede generalmente che l’addestramento del cane sia uguale all’istruzione delle reclute, e che pertanto di debba provare e riprovare in qualche campo d’istruzione fino a che il cane ha imparato. Se il cane non fa ciò che si vuole da lui, allora si ricorre alla frusta e al collare a punte (cosa ritenuta probabilmente normale con le reclute, escluso forse il collare! NdR). .
A coloro che la pensano in questo modo è necessario spiegare come stanno le cose, ma se per caso vi fosse qualcuno che volesse fare l’addestramento con questi sistemi, bisogna dire che egli non è degno di essere considerato un addestratore: anzi gli dovrebbe venir senz’altro proibito di tenere dei cani“.
L’autore è il Colonnello Johannes Schoenherr, un ufficiale dell’esercito tedesco, che scrive queste parole nel suo libro “Educazione e addestramento del cane da lavoro e utilità” del 1938.
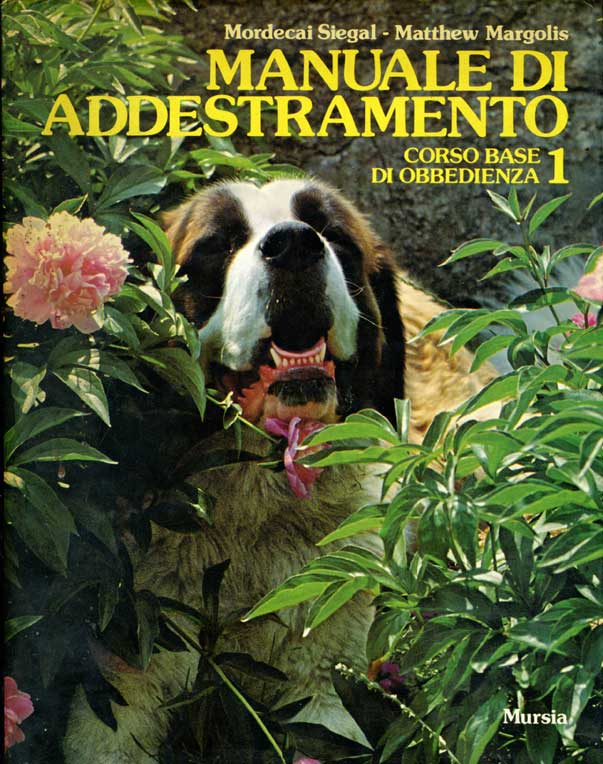 Nel 1973 viene pubblicato, in USA, “Good dog, bad dog”, quello che mi risulta essere il primo manuale di addestramento sotto forma di libro: autori, Mordecai Siegal e Matthew Margolis.
Nel 1973 viene pubblicato, in USA, “Good dog, bad dog”, quello che mi risulta essere il primo manuale di addestramento sotto forma di libro: autori, Mordecai Siegal e Matthew Margolis.
In italiano viene tradotto e pubblicato da Mursia nel 1977 proprio col titolo di “Manuale di addestramento – Corso base di obbedienza”.
Viene presentato come “parte I”. ..ma la “parte II”, che attendevo personalmente con molta ansia, non viene mai pubblicata, a dimostrazione del grande successo che deve avere avuto ‘sto manuale (il fatto che costasse 35.000 lire nel ’77 credo abbia avuto una certa influenza sul fatto che non sia mai diventato esattamente un best-seller).
In ogni caso, vi si trovavano già alcuni pilastri fondamentali dell’addestramento rispettoso del cane.
Per esempio, nel primo capitolo si legge: “Per addestrare con successo un cane il padrone deve mantenere la calma obiettività del professionista: ciò significa che le vostre frustrazioni non interferiscano nel vostro rapporto con l’animale (omissis); non bisogna in alcun caso inveire contro il cane o punirlo. Se il padrone ha avuto una giornata faticosa deve rinviare la lezione”.
“Bisogna avere pazienza, gentilezza e comprensione per i limiti emotivi del soggetto e le sue manchevolezze” (notare i “limiti emotivi”, che per quell’epoca rappresentano già un pensiero rivoluzionario: si considera il cane come un essere senziente!).
“Dimenticate la parola “punizione” e sostituitela con “correzione”.
“E’ importante dimenticare quei metodi conosciuti per sentito dire che ci sono stati tramandati attraverso i secoli assieme all’olio di serpente nei riti della stregoneria: è probabile che fosse Attila degli Unni colui che per primo strofinò il naso del suo cane nella sporcizia urlando e sgridandolo”.
E siamo nel 1973!
Certo, poi il manuale insegna come usare lo strappo correttivo con il collare a strangolo (specificando che lo strappo non deve durare più di un secondo e che non si deve assolutamente far provare dolore al cane, ma dargli una sensazione di fastidio) e spiega che per mettere il cane seduto si deve premere sul posteriore… ma siamo, appunto, nel 1973: i metodi sono quelli “dell’epoca”, ma il rispetto per il cane viene già tenuto in massima considerazione.
 Il grande pubblico, ovviamente, non sa nulla di tecniche addestrative. Né se ne interessa.
Il grande pubblico, ovviamente, non sa nulla di tecniche addestrative. Né se ne interessa.
Sui campi di addestramento arrivano tre categorie di persone: quelli che hanno un cane problematico, quelli che pretendono che “gli addestri il cane a fare la guardia” (e tu vagli a spiegare che quella è una dote innata, o c’è o non c’è: alla fine ci dovemmo inventare tutti qualcosa…) e quelli – tre gatti, che dire “quattro” sarebbe già un’esagerazione – che fanno o vogliono fare sport col cane.
Tutti gli altri proprietari di cani si arrangiano come possono e come sanno.
E’ opinione comune che il cucciolo “non possa ancora imparare nulla” e che l’addestramento possa cominciare intorno ai nove mesi: più frequentemente si parla di “un anno”.
Incredibilmente, i cani problematici sono una percentuale davvero minima rispetto a quelli odierni: e anche i “problemi” sono quasi sempre delle sciocchezze. Il cane tira al guinzaglio, salta addosso, scappa… cose così.
I cani aggressivi si contano sulle dita di una mano, e quasi sempre “si son rigirati al padrone” (termine tecnico delle Sciuremarie dell’epoca!) dopo che il padrone ha infilato una vera e propria compilation di errori educativi e/o di aggressioni e violenze rivolte al cane.
Tutto questo nonostante le razze canine più diffuse siano razze dal carattere tendenzialmente forte: da me arriva una vera overdose di pastori tedeschi (è vero che li allevo e che quindi posso essere ritenuta particolarmente “esperta” nella razza, ma è anche vero che questo è il cane più diffuso in assoluto a tutti i livelli, non solo come cane sportivo ma anche come cane di famiglia), seguiti da dobermann, rottweiler, schnauzer e alano. L’alano è considerato infatti un “cane da guardia” e molti intendono addestrarlo anche alla difesa personale.
Quelli che fanno sport col cane – escludendo i cacciatori, di cui nulla so perché non ho mai amato la caccia e non mi intendo di caccia – hanno praticamente una sola disciplina a disposizione: l’UD. Anche perché tutto il resto non esiste ancora.
Non esiste neppure – almeno, a me non risulta che esistesse – il concetto di “proprietario che va al campo col cane”: io scopro questa abitudine in Germania, dove vado a prendere monte, ma non spiccicando una parola di tedesco non è che possa fare grandi conversazioni. Per grazia degli improvvisati interpreti, però, riesco a capire che lì l’attività è sportiva nel 99,9% dei casi e i proprietari sono anche i conduttori (in gara) dei loro cani. Anche le nonnette cicciottelle che vedo zampettare in campo gridando “Fuss!” e “Platz!” si stanno, in realtà, preparando al prossimo SCHh3.
In Italia, il Sciurmario o la Sciuramaria che hanno qualche problema col cane lo “portano a scuola” nel senso che lo mollano all’addestratore, che ci lavora per un mesetto e poi glielo restituisce “educato”.
Il Sciurmario non si pone neppure lontanamente il problema di cosa possa fare, in quel periodo, l’addestratore.
Lo vede come io potrei vedere l’idraulico o l’elettricista che vengono a ripararmi qualcosa in casa: non ho idea di cosa combinino, non ci capisco niente, li lascio lavorare e alla fine mi aspetto di pagare il conto e di trovarmi il problema risolto.
Quando a fine addestramento spieghi il lavoro che hai fatto col cane e cerchi di far capire ai proprietari dove sbagliavano e cosa devono fare per non tornare al punto di partenza, alcuni fanno gli occhioni da bambini che fanno OHHHHHH e vedi proprio che gli si apre un mondo nuovo; ma (molti) altri ti dicono “sì, sì, va bene, ma tanto il cane lo guarda mia suocera, io non ho tempo, se dovesse ricominciare a fare lo scemo glielo riporto”.
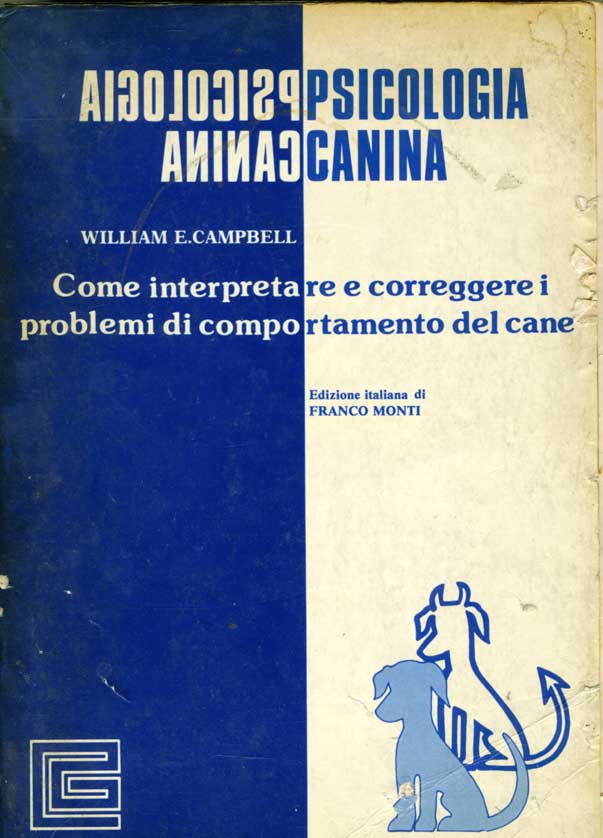 Anni ’80
Anni ’80
Inizia la rivoluzione, ovvero arriva la psicologia canina. In realtà c’era già stato qualche precursore (primo fra tutti Clarence Ellis Harbison, di cui abbiamo parlato in questo articolo), che già negli anni ’20 aveva pensato a terapie comportamentali per i cani: ma l’impatto mondiale lo ebbe William Campbell con il suo libro “Psicologia canina”, che in realtà era stato scritto nel 1975 ma che in Italia arrivò solo sei anni dopo. Purtroppo venne edito dalla C.G. Edizioni Medico Scientifiche di Torino, di cui praticamente nessuno aveva mai sentito parlare ad eccezione degli studenti di Veterinaria (anche perché era diretto prevalentemente ad essi, come si legge chiaramente nell’introduzione).
A me andò di puro culo: perché non solo avevo avuto la fortuna di frequentare proprio quella facoltà, ma ero stata anche allieva di Franco Monti.
Nell’81 avevo già lasciato l’università, ma bazzicavo ancora le librerie studentesche in cerca di testi che potessero essermi utili per il mio lavoro di allevatrice/addestratrice: e di quel libro bianco e blu, dalla copertina decisamente non troppo accattivante e dal titolo difficilmente leggibile, la prima cosa che mi colpì fu il nome del mio prof che aveva curato l’edizione italiana.
Fu così che mi accaparrai, credo, una delle primissime copie italiane di quel libro, che l’anno dopo era già diventato introvabile perché le teorie di Cambpell avevano “fatto il botto”.
Con la diffusione del libro, ma soprattutto del concetto di “psicologia canina” (fino ad allora considerato alla stregua di una barzelletta), gli addestratori “macellai” cominciarono ad essere sempre più aspramente criticati e l’utilizzo del rinforzo positivo come metodo educativo cominciò a prevalere.
Verso la metà anni ’80, sull’onda delle notizie che giungono dall’Inghilterra, considerata “molto avanti” in cinofilia – anche se in realtà lo è soprattutto nel campo delle esposizioni canine, che là sono già diventate da tempo un fenomeno di massa mentre in Italia sono decisamente più “di nicchia” (altri quattro gatti, insomma) e parecchio “rustiche” – cominciano ad apparire anche i primi campi i cui si tengono lezioni “cane-padrone”, accolte inizialmente con moltissima perplessità (“Come sarebbe, devo venire anch’io? Ma io ho altro da fare che star dietro al cane!”), ma poi con sempre maggiore favore.
Sicuramente uno dei motivi per cui molti ex-macellai si convertono al rinforzo positivo è la pura e semplice constatazione che la Sciuramaria, se le prendi a calci in culo il cane mentre lei è presente, si incazza.
L’altro motivo è che arrivano, da più parti del mondo, studi che dimostrano come il rinforzo positivo ottenga risultati più veloci e duraturi di quello negativo.
Questa teoria viene presa quasi universalmente per buona, tranne che in ambito agonistico, dove è richiesto un livello di performance sempre più elevato e difficilmente raggiungibile da chi sul rinforzo positivo non ci aveva mai lavorato prima, e quindi non lo sa usare granché bene.
Succede, così, che a vincere le gare (almeno quelle internazionali) siano ancora i macellai: e nasce un equivoco che non è stato del tutto superato neppure oggi, ovvero la convinzione che il cane possa arrivare alla perfezione solo con metodi coercitivi.
Comincia a diffondersi anche l’uso del collare elettrico, che come strumento di rinforzo negativo è indiscutibilmente il top, permettendo un uso particolarmente mirato della cosiddetta “punizione remota”.
Non vi so dire il periodo esatto in cui apparve sul mercato, perché la prima volta che ne sentii parlare pensai: “Questi sono scemi” e mai mi venne in mente di informarmi più a fondo. La prima volta che ne vidi uno “dal vero” credo sia stato a metà anni ’90, ma in ambito agonistico se ne sentiva parlare già da tempo.
Questo fu uno dei motivi per cui, in quel periodo, io abbandonai completamente l’agonismo.
Tra la metà e la fine degli anni ’80, sempre se la memoria non mi inganna, la scuola tedesca comincia ad essere influenzata, per quanto riguarda il lato agonistico, dai Paesi dell’Est europeo (tutti iper-coercitivi).
Sull’altro lato della medaglia, i Paesi anglosassoni spingono sempre più verso un maggiore rispetto per il cane e cominciano a porsi il problema etico dei metodi eccessivamente duri.
Il mondo agonistico li ignora (o li guarda con sogghigni di scherno); altri addestratori invece tendono l’orecchio, anzi aguzzano la vista in cerca di pubblicazioni difficilissime da trovare (Internet non esiste!) e cominciano ad interessarsi a quello che, di lì a poco, diventerà il “gentle training”, ma che allora veniva chiamato semplicemente “metodo inglese”, in contrapposizione a quello tedesco.





bell’articolo anche se non riesco a capire chi sono oggi i “macellai”. voglio dire chi utilizza correzioni con il collare a strozzo per educare il cane non può essere chiamato tale?! ci sono ancora educatori che utilizzano collare con le punte o elettrici e che rendono i cani degli automi?
quando tu dici che utilizzi molto il rinforzo positivo intendi correzione e poi carezza? coccole e vocine? o premi in cibo a macchinetta come i gentilisti?
Ho il miglior cane al mondo, educato a tutto e con un ottimo addestramento, tutta farina del mio sacco, recentemente haanche fatto sfigurare 4 cani da ricerca, ma questo non conta, anzi è ovvio: per me è il miglior cane al mondo, intelligentissimo ed educatissimo, e lo dicono tutti quelli che lo vedono, anche chi possiede un cane, c’è chi dice che sia meraviglioso, chi che ha un anima a dispetto degli altri cani, chi che è eccezzionale, e via dicendo.
Chi può ed ha vogLia di testarlo dimostrarlo ?
Il manuale di addestramento col Sanbernardo in copertina ce l’ho anch’io :))…. anche se l’ho preso usato negli anni 90. E confermo che malgrado l’impostazione “classica” e il consiglio di mezzi che oggi vengono definiti nei libri e nei programmi analoghi “inutili strumenti di tortura”…. beh.. dava consigli utili, funzionali, facili da mettere in pratica e che non hanno certo rovinato il rapporto col mio cane di allora… benché fosse una maremmana (detto tutto)… in realtà l’ho usato solo per fare le tre cose di base (seduto, terra, e ferma). Collare a strozzo per modo di dire perché…. con un cane che non tira il guinzaglio difficile. Lo mettevo sempre fisso perché se no il cane guardava in basso e lo faceva cadere :)… però lo strappo correttivo funzionava anche con sua dignità canina in persona. Basta non atteggiarsi a domatore… Un altro tra i libri datati che però è “rarissimo” e per niente conosciuto che per me è stato una vera “perla” è stato “L’apprendimento unificato : psicologia e addestramento dei cani di qualsiasi razza / Rosario Cosentino”. Che da leggere è una palla… cioè è noiosissimo. Ma semplicissimo… non è cosi’ macchinoso come i testi moderni. E una palla perché è ripetitiiiiiivo… Qui però siamo già sul verso il non coercitivo. Questo è l’ho usato per Amedeo…. i primissimi tempi appena preso dal canile quindi tutto da costruire. E i risultati parlano da soli.
Ricognizione davvero interessantissima, specialmente per chi, come me, non ha vissuto gli anni ’70-80 dal punto di vista cinofilo. Sono già curioso di leggere le prossime puntate. Credo si possa dire che la diffusione di prospettive, metodi e centri di buon livello professionale sia stata diversa nelle differenti aree del nostro paese ed in alcune di queste è stata più lenta e faticosa. Recandomi non molti anni fa a Milano e Torino ebbi modo di accorgermi che lì già da tempo c’erano professionisti che prestavano particolare attenzione alla motivazione, agli stati emotivi del cane ed al linguaggio del corpo nella relazione uomo-cane…e questo a prescindere dalle ‘appartenenze’ (“Gentilisti” o “Tradizionalisti”).
Se in 30 anni siamo cambiati così…tra altri 30?
La cosa positiva è che la cultura cinofila sta prendendo piede tra tutti i proprietari…di pazzi-isterici-violenti se ne vedono ancora in giro, ma sempre meno per fortuna!
Mi viene in mente che in tutte le casse negli autogrill ho visto il “dizionario uomo-cane”, un libretto simpatico e semplice, ma che dispensa consigli molto utili per i neofiti…la cultura cinofila non è più per pochi eletti!
«Incredibilmente, i cani problematici sono una percentuale davvero minima rispetto a quelli odierni». Questa frase mi ha incuriosita parecchio: s’è ‘mpazzuto lu cane o s’è ‘mpazzuto lu padrone? Ci siamo complicati la vita? Si stava meglio quando si stava peggio? Scherzi a parte: da cosa dipende secondo voi?
Credo che ai cani problematici si tirasse una botta in testa e via, come ai tempi di mia nonna. Oppure finivano legati dietro casa o in un box, che almeno non fanno danni. Almeno questo è quello che ho potuto capire.
Tra l’ altro i cani che fanno casino (=che non hanno ricevuto nessun tipo di educazione) che finiscono alla catena o nel box non passano mai di moda, purtroppo.
Mah…in parte poteva anche essere così (ma come hai detto, succede ancora adesso…e sinceramente non credo che la percentuale di personaggi che tiravano botte in testa fosse tanto superiore a quella attuale); così come chi lega il cane dietro casa continua a legarcelo anche oggi.
Per rispondere anche a Nico… io penso che si sia ‘mpazzuto lu cane perché s’è m’pazzuto lu padrone. Troppe aspettative, troppe responsabilità delegate ai cani, troppe seghe mentali (anche)…e il risultato è un aumento esponenziale dello stress, con le conseguenze che tutti possiamo vedere.
Be’, pero’ i cani erano stressati anche una volta, no? E sempre per mancanza di rispetto della natura del cane, adesso umanizzandolo (tutta la vita sul divano, nessuna chiarezza per il cane dei rapporti gerarchici in casa,..) una volta trattandolo come un oggetto (catena o box tutta la vita, nessun rapporto sociale,..). Quindi in teoria avrebbero dovuto esserci cani con problemi comportamentali anche allora…
Domanda, è tanto “stuppido” se penso che si risolvesse il problema sopprimendoli, al primo segnale che non obbediva?!
Io la mia prima copia di ‘Good Dog, Bad Dog? ce l’ho ancora, letta, riletta e straletta!! 🙂
Altro libro che ho amato molto, e non sono mai riuscita a trovare in italiano da regalare agli amici è: ‘Mother Knows Best’ di Carol Lea Benjamin
Interessantissimo!!! Grazie. Aspetto il seguito…
cara Valeria… leggere quest’articolo è stato un tuffo nella gioventù… io ho iniziato con
G. Couplet
IL CANE DA GUARDIA . DIFESA E POLIZIOTTO
Nona Edizione
Ulrico Hoepli – 1967
Prima edizione 1908 !!!
ecco alcuni consigli che trovavi
“Ricompensate il vostro allievo con una carezza o una leccornia qualsiasi, tostochè avrà compreso ciò che voi desiderate…
Non siate prodigo di carezze e non accarezzatelo che scientemente…
Battete meno possibile il vostro cane, se credete di essere obbligati a usare lo staffile dategli un solo colpo in caso di grave disobbedienza…
Fate il meno spesso possibile uso del collare detto di forza
e poi un grande passo in avanti :
A. Fatio
MANUALE PRATICO DI ADDESTRAMENTO DEL CANE
Nicolò Nicolosi – 1973
dove leggevi:
“Non sarà possibile addestrare un cane … se non quando il suo carattere sarà già ben definito, e cioè nel momento in cui l’animale avrà già preso … abitudini contrarie al lavoro che vi accingete ad esigere da lui…
Bisognerà usare mezzi repressivi e persino violenti. Ed è questo per l’appunto l’insieme di questi mezzi che viene definito addestramento”
Le illustrazioni contenute le vedrai a Verona…
Uhhh il Couplet! Ce l’avevo anch’io! (o forse ce l’ho ancora…addentrarsi nei meandri della mia libreria è un’impresa improba!).
Il Fatio invece non l’ho mai comprato: lette du’ righe, mi era già bastato e avanzato…
“tostochè” non ha prezzo!
cmq bel “salto” in avanti vedo…
Oh, ma questa rubrica e’ interessantissima!! E’ un pezzo che intendo informarmi un po’ sulla “storia” dell’addestramento…grazie! 🙂